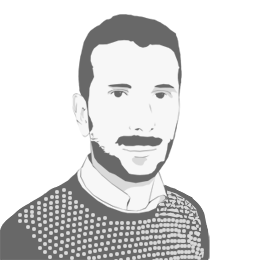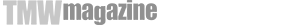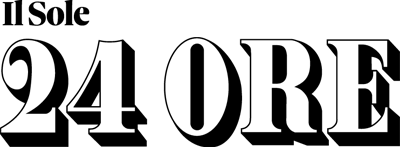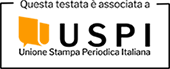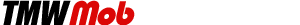Retegui, Tigre, l’Argentina e la storia del calcio italiano che ritorna (almeno speriamo)
 TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBMica male Tigre. Mettendosi alle spalle la Plaza de Mayo, la Buenos Aires propriamente detta, la sua congestione, il traffico umano e rumoroso, accompagnato da voci col volume italico ma più creativo, qualche volta sbucano posti in cui è la serenità a farla da padrone. Esci dalla stazione, vedi il fiume, ti avvicini e tutto sembra meno caotico.“Espectacular”, condisce con la solita grandeur il porteno (i francesi saranno pure gli americani del mondo ma l’abitante di Buenos Aires, li supera tutti per egocentrismo, dove l’io è la propria città). Io resto al mica male. Soprattutto si nota una tranquillità, in questa zona nord, certamente non consueta, a meno che ci si avvicini al “José Dellagiovanna”, lo stadio che prende il nome dal fondatore del Club Atletico Tigre. Lì, l’anima futbolistica prende il sopravvento.
Nella scorsa stagione la squadra ha giocato forse il miglior calcio d’Argentina, insieme a Huracan e Argentinos Juniors, ed è rimasta appiccicata per un lungo periodo alla testa della classifica, dove alla fine è svettato il Boca Juniors. La squadra di Diego Martinez è stata trascinata dalla coppia d’attacco formata dall’ex Inter Facundo Colidio, investimento oneroso della squadra nerazzurra che non ha però mai dato frutto, e da Mateo Retegui, che è un po’ un enfant du Pays, visto che in queste zone è nato ed era arrivato al Matador, nomignolo del club, in prestito dal Boca. Che lo ha svezzato nelle sue giovanili poi lo ha un po’ prestato in giro. Non certo un giocatore fine, ma uno che anno dopo anno era cresciuto, con una fame e una voglia che fanno ben sperare se guardi al suo futuro. Però, c’è un però grande, improvvisamente ha trovato la via del gol con una facilità impressionante. E’ lavoro, ma anche convinzione. Un lavoro di testa in cui certamente c’entra anche il padre di Retegui, El Chapa, monumento dell’hockey su prato, sport piuttosto diffuso in Argentina e con una sua dignità: non sono mancati tecnici che sono passati proprio da questa pratica al calcio (Ariel Holan, ex Independiente ora nel campionato messicano col Leon, l’esempio più noto), e Retegui senior era pronto a fare il grande balzo, come assistente di Carlitos Tevez al Rosario Central. Poi il rapporto si è rotto, e Carlos Retegui ha preferito continuare nella politica, dopo tanti anni di sport ad alto livello (dove ha coinvolto anche la figlia, Micaela, una delle Leonas, la seguitissima nazionale femminile di hockey su prato argentina).
Famiglia di sportivi, etica di rispetto per il gioco, impegno, maturazione: quando Roberto Mancini lo ha chiamato per la nazionale azzurra in tanti però si sono stupiti, a cominciare dal Mancio: “ non pensavo dicesse subito sì, credevo attendesse, e invece è stato entusiasta di venire con noi”. In ottica ricerca di un nuovo attaccante per la Nazionale, l’occhio lungo, e generalmente fine del nostro CT rappresentano davvero un motivo di speranza, unita alla voglia di migliorare di Retegui.
A chi storce il naso, qui dai noi, che trova la chiamata di un ragazzo non formato nel calcio italiano, una specie di lesa maestà verso la nostra storia (e sono più di quelli che si sentono, ahimé), tocca appunto richiamare la storia del calcio italiano. E torniamo a Tigre, in quella località che anni fa forse non era così amena come oggi. Il pastaio della zona aveva chiesto un aiuto a uno che aveva giocato, e perso, la finale mondiale del 1930, indossava la maglia argentina, e veniva battuto dall’Uruguay. A Tigre era andato a trovarlo Renato Cesarini, un genio del calcio nato a Senigallia che in Italia sarebbe tornato dopo aver contribuito a creare la Maquina del River Plate, una delle squadre più importanti della storia. Il Cè, quello della zona, punto di riferimento calcistico ma non solo dell’avvocato Gianni Agnelli (chi portava prima l’orologio sul polsino?) chiedeva al pastaio, Luis Monti, di farsi un giro in Italia, alla Juventus. A Torino sbarca in sovrappeso, ma sulle qualità calcistiche garantiva Cesarini, e i geni non sbagliano. Presto il campo gli avrebbe dato ragione, la squadra della famiglia Agnelli guidata da Carlo Carcano, uno dei primi grandi tecnici del nostro Paese, avrebbe vinto cinque titoli di seguito, come Monti protagonisti in quattro.
Poi, la Nazionale.
Vittorio Pozzo gli mette l’azzurro appena entra in peso forma. Con l'argentino, ex pastaio di Tigre, protagonista in campo l’Italia diventa per la prima volta campione d’Italia. Nella finale di Roma contro la Cecoslovacchia il gol che riacciuffa i rivali, prima del gol vittoria di Schiavio, è di “Mumo” Orsi, lui pure argentino di passaporto. La prima delle nostre quattro stelle che giustamente orgogliosi portiamo sul petto, è merito anche di chi in Italia non è nato ma ha scelto di rappresentarla con serietà e rispetto. Magari meglio di chi in questo Paese è nato. Anche perché figlio di una diaspora che l’Italia l'ha sempre amata, magari anche solo da lontano. Se vogliamo parlare della storia del nostro calcio, cominciamo da lì (nella speranza che Retegui ci dia una mano per farla risplendere).