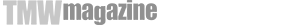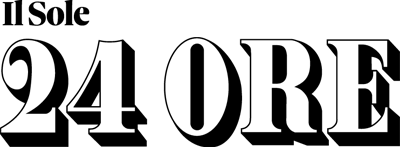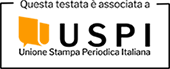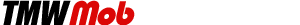Vlahovic, Jovic, Matic, Kostic and co. La Serbia d’Italia fa sognare. La storia del calcio ha un’ottica differente dai Balcani
 TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBMolti pensano che Pelé scelse di giocare la sua partita d’addio, il 18 luglio del 1971, contro la Jugoslavia perché, se fosse nato in Europa, sarebbe stato solo ed esclusivamente lì. Qualcuno crede la nazionale jugoslava campione del mondo under 20 nel 1987 sia la selezione con più giocatori capaci di vincere una partita con un paio di giocate in solitario, della storia del torneo. Diversi suppongono che se la Jugo non avesse subito lo stop dall’Uefa, non ci sarebbe stata nessuna favola danese nell’Europeo del 1992.
Tutti, proprio tutti, sanno che la Jugoslavia non esiste più, ma, e c’è fortunatamente anche un MA, il calcio di quella fantastica terra continua a produrre talento, come e più di una volta. I croati, trascinati da un pallone d’oro, hanno sfiorato un mondiale, l’ultimo giocato, i serbi, cioè i rappresentanti dell’altra grande anima calcistica della Nazione costruita e retta da Tito, stanno arrivando, e hanno formato una nazionale che per talento può arrivare molto lontano in Qatar, con in panchina uno dei giocatori più iconici della sua storia, Dragan Stojkovic. Buona parte di quel gruppo è oggi protagonista nella Serie A italiana.
Molti big di quel gruppo che ha messo dietro nel girone di qualificazione al Mondiale il Portogallo, sono appena sbarcati da noi. Jovic, Kostic, Matic e Radonjic hanno appena debuttato, Vlahovic, Milinkovic Savic, Milenkovic, Djiuricic, Lazovic e Ilic si sono decisamente già fatti apprezzare, e non poco. La formazione di calciatori in Serbia è diffusa sul territorio, molto spesso le due scuole migliori, quella del Partizan e quella della Stella Rossa, hanno un intervento diretto nel percorso di crescita. Si alternano ciclicamente come risultati, anche storicamente. Se i bianconeri sono stati i primi a sfiorare la Coppa dei Campioni (rimonta subita in finale dal Real Madrid di Gento, nel 1966), la Crvena Zvezda è riuscita a conquistarla, a Bari contro il Marsiglia, nel ‘91 poco prima dello smembramento dello Stato slavo. Il campionato serbo ha avuto sedici edizioni, i due club di Belgrado si sono divisi equamente gli scudetti, senza nessuna inclusioni di altri: inizialmente la faceva da padrone il Partizan, negli ultimi hanno detta legge la Stella Rossa, guidata da Dejan Stankovic, che ha dominato gli ultimi tre tornei. L’ex centrocampista di Lazio e Inter, è cresciuto nel quartiere di Zemun, una specie di vecchia città inghiottita dalla parte occidentale di Belgrado. È un’area con un profondo sentimento calcistico, ma anche militare: qui c'era la più importante base aerea dell'esercito jugoslavo, il quartier generale dell'aviazione e un'accademia militare. E non a caso sede del Partizan, che era infatti la squadra della JNA, l’esercito jugoslavo nato dalla resistenza (appunto: partigiani). Di più, il Partizan sarebbe stato il riflesso di ciò che la JNA rappresentava allora nella Jugoslavia plurinazionale, del comunismo fatto in casa e non allineato con Mosca: l'ideale federale jugoslavo, con soldati e comandanti sloveni, croati, serbi, bosniaci musulmani, montenegrini, kosovari, macedoni, serbi, bosniaci croati o serbo-croati. Se l'esercito, come massima espressione del regime centralista e unitario, custodiva questo ideale e alzava la spada dell'opposizione ai duri nazionalismi regionali, il Partizan sarebbe servito come emblema sportivo del vero nazionalismo jugoslavo, come vessillo del sentimento pan-jugoslavo che Tito ha sempre protetto. E non a caso il croato Franjo Tudjman (poi padre della patria della Croazia nata dalla dissoluzione), ne è stato presidente, negli anni d’oro. La Stella Rossa è stato un club storicamente più legato al nazionalismo serbo e, in qualche maniera, alla Chiesa ortodossa del Paese.
Entrambe hanno avuto nella formazione la loro grande forza, anche perché proprio grazie alla costruzione dei talenti fatta in casa il Partizan stupì l’Europa e quasi sorprese l’Europa: “Partizanove Bebe” li chiamavano, proprio perché arrivavano in molti dal vivaio. La scuola jugoslava è una branca della scuola danubiana, un calcio fatto più di palleggio che di forza fisica (al Partizan era passato Geza Kalocsay, il tattico di Gusztav Sebes, CT dell’Aranycsapat, la squadra d’oro ungherese dei Puskas, Kocsis, Bozsik, Hidegkuti e compagnia). Tra gli anni Cinquanta e Sessanta giocava già una specie di 3-1-2-4, un ibrido tra la cosiddetta “piramide danubiana” (il 2-3-5) e il 4-2-4 che portò al Brasile la sua prima Coppa del Mondo, nel 1958. Con la forza dei requisiti tecnici di base, promosse dalla cultura danubiana, gli jugoslavi praticavano un calcio attrattivo, piacevole da osservare anche per un pubblico neutrale, uno stile brillante e con qualche dose di rischi, che però fruttà risultati eccellenti: la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Roma, l’argento a Helsinki ‘52 e Melbourne ‘56, i secondi posti ai Campionati Europei del ‘60 e del ‘68 e il quarto posto alla Coppa del Mondo in Cile.
Queste basi non sono mai state dimenticate, la produzione di calciatori continua anche se a differenza della realtà croata, dove la Dinamo Zagabria è assoluta accentratrice del movimento (degli ultimi 17 campionati ne ha vinti, e per lo più dominati, 16), in Serbia c’è un potere diviso e diffuso, oltre a una minore capacità di trattenere per qualche stagione i giovani (e poi magari venderli a prezzi maggiorati). La Serbia che arriva in Qatar gioca un 3421 pieno di qualità in ogni reparto, e il ritmo offensivo del gioco lo gestisce Dusan Tadic, formatosi nella piccola ma fruttuoso scuola di calcio del Vojvodina, costruita dal grande Vujadin Boskov, che lì ha allenato per quasi un decennio. Davanti tanta qualità, e un gusto per il gioco che sa di passato e si sposa col presente fatto di atletismo e pensiero sviluppato.
La memoria rivive, insieme a un sogno lontano. Non esiste più la Jugoslavia, esistono, per fortuna del calcio, tanti figli calcistici di quella terra. E quello stato d’animo, unico. Fine, scostante, qualitativo, sanno estasiare e sconsolare anche nella stessa gara ma non hanno mai abbandonato lo spirito del gioco. Pelé sarebbe davvero nato lì.