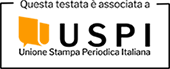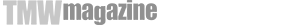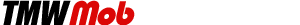TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBSensazionale! Il calcio di rigore sacrosanto e la giustizia bendata!
Vero è che il calcio è uno sport come si suol dire di contatto, e che quindi è concessa qualche carezza all’avversario, ma teniamo bene a mente che non ha le stesse regole del rugby. Il calcio di rigore è un qualcosa di semplicemente elementare: si assegna alla squadra che attacca quando chi difende in area ostacola contra legem l’azione.
Giusto o sbagliato, bello o brutto che sia, il calcio di rigore è forse l’unico momento durante una partita di calcio in cui la sfida si riduce a un duello tra due individualità, e che non tiene più minimamente conto di tutto quello che è stato in un match lungo e combattuto da ventidue uomini. Non importa chi ha giocato meglio, chi ha avuto più occasioni o, banalmente, chi è più forte, perché a quel punto tutto si azzera, e restano solo i nervi; i nervi di chi tira e di chi para. Se non fosse davvero così, un attimo letterario, uno scrittore innamorato del calcio come Osvaldo Soriano non avrebbe mai potuto non sfruttare una situazione così carica di dramma e tensione per scrivere una storia. Il suo racconto Il rigore più lungo del mondo, inserito nella raccolta Pensare con i piedi, è considerato uno dei più bei racconti mai scritti sul calcio. Soriano usa in realtà la forza emotiva di un calcio di rigore come perno attorno al quale far ruotare i ricordi della propria adolescenza quando, assieme ad amici e gente del paese, andava a vedere le partite della squadra locale. Sono gli anni Cinquanta dei campi in terra, e i frequentatori del circolo che bevono e giocano a carte sono gli stessi che poi vanno in campo la domenica a giocarsi il campionato della piccola regione argentina della Valle del Rio Negro. Gli spalti sono mezzi vuoti e se si riempiono è solitamente per deridere quei giocatori troppo scarsi e svogliati; sono gli stadi malconci di tutte le periferie del mondo, dove nelle domeniche troppo fredde o troppo calde non c’è nulla da fare se non andare a sostenere la propria squadra di calcio. Quel lungo rigore fu battuto dopo una settimana, e quell’attesa non è altro che l’apice della suspance sportiva, metafora perfetta dell’attimo che diventa tempo sospeso dilatato all’infinito, carico di incertezze e aspettative, percepibili negli sguardi tra i due e nella rincorsa di pochi passi in attesa del fischio dell’arbitro. Vorresti solo finisse presto, ma più desideri che tutto finisca in fretta, più il tuo cervello è risucchiato in quella schiacciante eternità emotiva che si gonfia di dubbi e responsabilità. L’attesa massacrante del rigore è l’orlo del baratro ideale, tra la gloria e il nulla, su cui trasformare un portiere di paese qualunque quasi quarantenne come el Gato Diaz, in una figura triste e romantica, un personaggio letterario a tutti gli effetti, tormentato e combattuto, come solo chi è a un passo dall’essere l’eroe della gente oppure venire dimenticato assieme a tutti nella polvere di un campo semi sperduto della Patagonia argentina. Non vi dico cosa accadde, se fu sacrosanto concederlo, se le cose andarono come davvero Soriano scrisse: quelle pagine meritano di essere lette e quell’attesa dipinta su di esse vi farà sognare. Posso qui solo dirvi che il calcio rigore è una cosa seria se fa parte della letteratura e la letteratura precede sempre la vita: non la copia, ma la plasma a suo uso.
Diversamente è accaduto domenica ad ora di pranzo, dove un rigore non c’è stato, forse per timore di aspettare una settimana prima di batterlo sul serio! Negli ultimi concitati minuti di Juventus-Cagliari l’ala destra bianconera, il folletto portoghese Francisco Conceição, alto 160 centimetri, a velocità supersonica, palla al piede, entra in area di rigore. Il roccioso difensore rossoblù slovacco Adam Obert, alto 186 centimetri, rincorrendolo, gli mette una mano sulla spalla, spingendolo, facendogli perdere l’equilibrio, infine atterrandolo. È concesso nel regolamento? No. Allora è calcio di rigore. Ci sono dubbi sulla causa (manata con spinta) e sull’effetto (caduta)? No. Anzi si, anzi no. C’è addirittura una certezza per l’arbitro signor Marinelli di Tivoli: l’attaccante juventino ha simulato, viene punito con un secondo cartellino giallo e cacciato dal terreno di gioco. A questo punto un dubbio è legittimo: e se a dissimulare sia stato proprio la giacchetta nera?
Cominciamo dalla differenza tra simulare e dissimulare. In genere, se uno simula qualcosa, finge un comportamento o un pensiero che non sono i suoi; se li dissimula, non li lascia trasparire. In entrambi i casi c’è astuzia, accortezza, ma simulando ci si attribuisce qualcosa che non si prova, mentre dissimulando lo si nasconde. La differenza tra i due verbi è la stessa che corre tra i due sostantivi che ne derivano, come si legge in questa bella definizione del trecentesco Buti, citata dal Tommaseo: «Simulazione è fingere vero quello che non è vero, e dissimulazione è negar quello ch’è vero».
Perché il portoghese avrebbe dovuto fingere una caduta avendo la possibilità di concludere l’azione con un probabilissimo suo meraviglioso gol della vittoria? Anche i famosi posteri manzoniani non saprebbero dar sentenza a questa domanda; mentre invece sulla dissimulazione (apparentemente immotivata) tanti arduamente sentenziano, senza però dar seguito a ciò che sarebbe giusto fare. Il vice designatore arbitrale Gervasoni in tv ha dichiarato che la decisione dell’arbitro Marinelli di ammonire per simulazione Conceição è sbagliata; il designatore Rocchi conferma il giorno dopo quanto detto dal suo vice: Conceição viene squalificato. C’è qualcosa che non quadra. Un modo simulato di far giustizia?
Alla fine del Cinquecento compare un nuovo attributo simbolico nella raffigurazione della giustizia: la benda. Già intorno al 1593, Cesare Ripa nella sua Iconologia prende atto della presenza di caratteri discordanti nell’iconografia della Iustitia. Egli, da un lato, afferma che la giustizia è «secondo che riferisce Aulo Gellio» una donna «con gl’occhi di acutissima vista, con un monile al collo, nel quale sia un occhio scolpito» affinché «i ministri della Giustizia […] con acutissimo vedere, penetrino fino alla nascosta et occulta verità»; dall’altro, essa è una donna bendata vestita di bianco «perché il giudice dev’essere senza macchia di proprio interesse, o di altra passione, che possa deformar la giustizia, il che vien fatto tenendosi gli occhi bendati, cioè non guardando cosa alcuna della quale s’adopri per giudice il senso nemico alla ragione».
Alla luce di queste premesse, è evidente come la benda sugli occhi della giustizia costituisca un’immagine altamente contrastante con l’antico attributo della vista acutissima. Sull’argomento ha provveduto a far chiarezza lo storico del diritto Ernst von Möller, il quale nel 1905 ha scritto un breve saggio sulle origini dell’attributo della cecità. Egli fa coincidere l’atto di nascita della prima rappresentazione della giustizia bendata con l’incisione a stampa apparsa all’interno del poema satirico redatto dal giurista Sebastian Brant nel 1494 a Basilea intitolato La Nave dei folli. Qui si narra infatti di un viaggio per nave verso l’immaginario paese della Follia e deride i vizi e le debolezze di chierici, laici, nobili e letterati, ma soprattutto di coloro che facevano parte del mondo professionale giuridico, poiché era a questo che Brant, cancelliere a Strasburgo, apparteneva. In quest’opera la figura femminile della giustizia, attribuita probabilmente alla mano artistica di Albrecht Dürer, oltre che con i consueti attributi della bilancia e della spada, è cieca, raffigurata con una benda postale sugli occhi da un pazzo riconoscibile dal berretto a sonagli. Von Möller osserva come la cecità nell’opera di Brant sia non un attributo simbolico al pari della bilancia e della spada, bensì un fortuito accadimento negativo, quasi un ostacolo creato dalla follia umana, da eliminare strappando la benda dagli occhi della giustizia per restituirle il suo oculos rectos; difatti, come paradigmaticamente spiegato dal filosofo Michel Foucault, «la follia e il folle diventano personaggi importanti nella loro ambiguità: minaccia e derisione, vertiginosa irragionevolezza del mondo, e meschino ridicolo degli uomini». Cosicché la Iustitia, vittima del gesto beffardo del folle, è allo stesso tempo derisa e corrotta perché la benda, sfigura, toglie l’identità, induce ad una cecità che è anche metafora della perdita di senno; in altri termini, siamo dinanzi ad una giustizia impazzita, cieca, che non sa più distinguere il bene dal male e che, perciò, non ha più i tratti dell’aequitas.
Arbitri, varisti, designatori, commentatori, giornalisti et alii. Mi auguro, e ne son certo, che voi siate seguaci di Aulo Gellio e che le bende le usiate soltanto per giocare alla Pentolaccia, evitando così di far diventare ogni storia di rigori una storia di fantasmi.
Roberto De Frede
 interLega A, vince Simonelli ma ora deve essere proclamato. L'ultima manovra del blocco Lotito
interLega A, vince Simonelli ma ora deve essere proclamato. L'ultima manovra del blocco Lotito
 sassuoloDionigi: "Solo il Sassuolo è fuori categoria. Serie B senza playoff? Colpa di Palermo, Samp e Cremonese"
sassuoloDionigi: "Solo il Sassuolo è fuori categoria. Serie B senza playoff? Colpa di Palermo, Samp e Cremonese"
 milanHellas Verona-Milan 0-1: Reijnders eletto MVP della partita
milanHellas Verona-Milan 0-1: Reijnders eletto MVP della partita
 romaLIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Roma 1-3 - Misitano a segno
romaLIVE PRIMAVERA 1 - Inter-Roma 1-3 - Misitano a segno
 romaLe probabili formazioni di Roma-Parma
romaLe probabili formazioni di Roma-Parma
 milanPrimavera, le formazioni ufficiali di Monza-Milan: Ibra titolare
milanPrimavera, le formazioni ufficiali di Monza-Milan: Ibra titolare
 cagliariDavide Nicola in conferenza stampa. Dalle 12:15 la nostra diretta testuale
cagliariDavide Nicola in conferenza stampa. Dalle 12:15 la nostra diretta testuale
 PadovaOggi - Cittadella-Reggiana, scontro salvezza ad alta tensione
PadovaOggi - Cittadella-Reggiana, scontro salvezza ad alta tensione