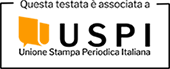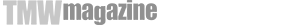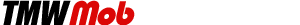TUTTO mercato WEB
TUTTO mercato WEBGli eroi in bianconero: Sergej ALEJNIKOV
Un po’ Boniek e un po’ Goria – scrive Adalberto Scemma su “Hurrà Juventus” dell’ottobre 1989 –. Di Zibì ha i riccioli cespugliosi color carota; di Goria (Amedeo, naturalmente, quello della Ruta) ha il baffo pendulo in similpelle, il naso arguto a frangiflutti e il sorriso in missione speciale, un sorriso così veloce da consolidargli di colpo anche la fisionomia. Di suo, senza la presunzione del copyright, Sergej Alejnikov ci mette tutto il resto, compresi gli scampoli di curiosità sempre innescata. Curiosità per un mondo non soltanto calcistico che gli mostra l’altra faccia della sua luna. Curiosità, anche, per quelle vibrazioni nuove che lo carezzano sottili; e che dovrà ascoltare e catalogare con pazienza e con cura, senza fretta, per non correre i rischi di Sasha, per non interrompere il filo nevrile della sintonia.
Ma non sembra il tipo Sergej Alejnikov, da lasciarsi impressionare dalle novità, neppure da quelle così improvvise da rischiare – come la chiamata della Juve – di stravolgere il giro consueto di un’esistenza già consolidata in chiave di serena gestione dell’ordinario: il presente di calciatore di Stato, con i benefici annessi e connessi, e il futuro di insegnante di educazione fisica o magari di colonnello, considerando la carriera di riflesso nell’esercito. Di paura, infatti, nemmeno l’ombra. «Ho esperienza da vendere», ha dichiarato a Novogorsk proprio alla vigilia del festoso, commovente omaggio a Lev Yashin, «e questo alla Juve non è certo un salto nel buio. Ho giocato in Messico, al Campionato del Mondo, e anche in Germania agli Europei. Il mio atteggiamento nei confronti del lavoro che svolgo non cambierà: ce l’ho sempre messa tutta, stiano tranquilli i tifosi, e continuerò su questa strada. L’ambientamento, le difficoltà, gli errori inevitabili: nel conto ci metto un po’ di tutto. Ma non sono questi i veri ostacoli. I problemi nascono quando nella testa di un calciatore si inceppa la macchina che fabbrica gli stimoli, quando si blocca il flusso della motivazione. Non è il mio caso. Io vado a Torino per vincere e per farmi ricordare: non voglio passare inosservato. E poi le prove impegnative mi stimolano, sono una scommessa continua. Credo di essere un giocatore nell’anima: è questo il mio temperamento».
Un tipo deciso, Sergej, con un’arma segreta, quella della modestia, sempre a portata di mano. Ma è una modestia in esibizione controllata, la sua: frutto del pragmatismo, quindi reale, più che del retaggio di un’educazione fuorviante. «Il futuro», sottolinea, «mi incute rispetto ma non paura. Come potrebbe essere diversamente? Non sono un fenomeno, nessuno deve pensare a me come a un fuoriclasse, eppure gioco ad alto livello da una decina d’anni; ne ho viste e passate di tutti i colori. Per dire che uno ha esperienza, a Minsk si usa una frase che da voi fa sorridere: “Ha mangiato un pud di sale”. Il pud è una misura nostra, corrisponde a sedici chili, quindi è un bel mangiare. Ebbene: il mio pud è già in archivio, non possono più tremarmi le ginocchia».
È stato Stefano Bizzotto, bolzanino della «rosea», tedesco e inglese parlati a raffica, il primo ad allacciare un ponte telefonico con Sergej a Minsk: da allora, l’atteggiamento di questo russo dall’inesauribile carica umana nei confronti del calcio e della vita non è cambiato. Le parole di quella prima intervista «di getto» si profilano senza mutamenti di rotta in tandem con quelle che pronuncia oggi, a esperienza italiana gradualmente maturata e a comprensibili traumi da ambientamento già filtrati con disinvoltura. Come dire che la chiave di lettura, al di là dell’imprescindibile simpatia istintiva, rimane pur sempre la freddezza, o quantomeno una ammirevole capacità di autocontrollo.
A incidere, naturalmente, c’è anche la naturale adattabilità degli slavi alle situazioni nuove. Sasha Zavarov è un ucraino, popolo semplice, privo di spigoli, ma Sergej Alejnikov è di razza soltanto in apparenza affine e in realtà molto più corsara, corroborata nelle sue componenti di inventiva e di fantasia da una vistosa e duratura presenza dal XIII secolo agli albori del ‘700 dei polacchi e dei lituani. La Bielorussia, o Russia Bianca, ha subito nei secoli successivi spartizioni costanti e ha patito senza patirlo il giogo dei russi di Mosca e di Kiev (così raccontano gli annali quella storia sovietica) finendo poi per assestarsi nell’attuale configurazione geografica soltanto settant’anni fa. La sua gente ha il calore dei russi, la loro voglia di cantare, e ha quel grano di follia che è quasi una costante nei polacchi e nei lituani piazzati e spiazzati (quasi una regola i mutamenti territoriali) al di là del confine.
Bene al di qua del confine, proprio al centro della Bielorussia, c’è invece Minsk, la città di Sergej Alejnikov. Un milione e mezzo di abitanti, un’impronta ormai più industriale che agricola, una vaga (ma per Sergej fondamentale) somiglianza con Torino. E la Dora Riparia? C`è il fiume Svisloc che ha un andamento sinuoso e che carezza Minsk con tutte e due le sponde. Con un po’ di fantasia ci si può immaginare persino il Valentino. Ma quale sarà, per Sergej, l’immagine traditrice capace di riproporgli lo Svisloc e la nostalgia?
La nostalgia, nei primi giorni torinesi, si chiamava soprattutto Natasha, la moglie dolce e cara, e Artiom, il piccolino, due anni e mezzo soltanto, tetragono a quelle sollecitazioni calcistiche cui gli Alejnikov sembrano incapaci di resistere. «Gioca a calcio», dice Sergej, «anche il minore dei miei fratelli, Anatoly. Ha vent’anni e veste naturalmente la maglia della Dinamo Minsk. Gli altri giocano per hobby, non hanno avuto la fortuna di incontrare un maestro come Oleg Michailovich Basarnov: gli devo molto, è stato lui, alla scuola di calcio numero cinque, il “Djussh 5”, a insegnarmi tutto quello che c’era da insegnare a un giovane; La mia carriera? Dal “Djussh 5” alla Burevetsnik, la squadra della mia scuola, e poi alla Dinamo. Qui ho trovato Eduard Malofeev, un grande tecnico, e ho vinto uno scudetto».
È stato Malofeev, stimatissimo in patria, famoso all’estero soltanto perché venne cacciato alla vigilia dei Mondiali messicani per far posto a Lobanovski, a trasformare Alejnikov da attaccante in centrocampista d’attacco e poi in regista difensivo: il primo passo concreto in direzione delle teorie poi propugnate da Lobanovski, latore di un’ideologia calcistica che privilegia l’atleta «universale»” nei confronti del fuoriclasse iperspecializzato. E non è casuale, forse, l’insistenza con cui Lobanovski avrebbe continuato a chiamare Sergej in Nazionale: Dasaev dello Spartak e Alejnikov della Dinamo Minsk sono stati gli unici, dai Mondiali del Messico in poi, a perforare il blocco apparentemente inalterabile della Dinamo Kiev.
«In Nazionale», osserva Sergej, «sono già in “zona Netto”. È una zona prestigiosa, un club riservato. Ne fanno parte tutti coloro che, come il grande Igor, hanno superato le cinquanta presenze. Sono stato il diciassettesimo giocatore sovietico, per la cronaca, a raggiungere questo traguardo: ho tagliato il filo l’anno scorso, 19 ottobre, partita di qualificazione mondiale contro l’Austria. Il mio debutto? Quattro anni e mezzo prima a Hannover: vinsero i tedeschi per 2-1 con una rete di Brehme proprio all’ultimo minuto. Ma avrò tutto il tempo, qui in Italia; di restituire a Brehme quel “favore”. Non sono un goleador, però non c’è stato un anno che mi abbia visto all’asciutto. In 220 partite di Serie A ho messo a segno 31 reti, le ultime due in questo campionato. Il mio top? Otto bersagli nell’82, l’anno dello scudetto vinto con la Dinamo. Ma giocavo ancora da attaccante, segnare era abbastanza normale».
C’è una frase che Sergej ha pronunciato prima ancora di mettere piede a Torino e che Emanuele Novazio, il corrispondente de «La Stampa» da Mosca, ha puntualmente registrato: una frase che la dice lunga sul suo pensiero. «Il calcio in Italia è più che uno sport, è un tipo d’arte senza la quale non si può immaginare l’Italia». Semplicissima, d’accordo, ma non semplicistica, se la analizziamo con attenzione.
Perché a parlare di arte, riferendola al calcio, non è un artista del pallone, un fantasista alla Maradona o (se volete) alla Zavarov, ma un giocatore duttile che si autodefinisce «gregario». Ed è proprio questa sorta di rispetto per un mondo e per un ambiente da affrontare in umiltà ma «senza paura» a qualificare il carattere e la sensibilità dell’uomo. «Vorrei guadagnare soldi», dice ridendo Sergej, «ma anche tifosi. Tanti, come quelli che ho lasciato a Minsk e che ritroverò tra tre anni con un altro “pud” di sale nel mio magazzino privato. Chiedo troppo? Spero di no. Nella mia carriera ho sempre corso molto, non ho mai avuto paura di faticare, conosco l’abitudine al sacrificio. Ho grande volontà e tecnica discreta, però non aspettatevi tutto e subito. Io vi conquisterò a poco a poco».
L’ammirazione di Sergej, dichiarata, è per Van Basten («Il migliore del mondo, in questo momento») e per Gullit («Deve guarire presto: il confronto diretto con lui mi affascina»). Voglia di rivincita dopo la scoppola di Monaco agli Europei? Sergej dice di no. «Perdemmo dall’Olanda meritatamente ma Van Basten, visto che lo marcavo io, ebbe una fortuna sfacciata, pescò l’asso…».
Il tempo per voltarsi indietro, oggi come oggi, non c’è davvero. Il presente di Alejnikov è così infittito di avvenimenti da spingerne qualcuno verso il futuro, come in una giostra gioiosa. Dalla Zigulì settimo modello («Un gioiellino, non le manca niente») alla Thema 16 valvole, dall’appartamento di Gorki Park alla villetta in collina, dal milione e mezzo al mese ai 200 e passa milioni all’anno: ce n’è abbastanza perché sia necessario toccare impercettibilmente il freno. Dal 12 agosto, prima giornata juventina, a oggi, le ore sono filate così veloci da offrire un ricordo «blocco unico». Il momento indimenticabile? Il primo: l’impatto con il povero, stupendo Gaetano Scirea e Alberto Refrigeri, maestri di cerimonia, e con i tifosi dello Juventus Club Augusta Taurinorum. C’è una foto di Alejnikov nell’atto di stappare una bottiglia di champagne, con la sciarpa bianconera al collo e un gran sorriso sulle labbra. Il tappo è saltato con un gran botto ma a portare fortuna è stato soprattutto il sorriso di Sergej. Contagioso. Coinvolgente. Calibrato. La sintonia con Sasha Zavarov? Calibrata anche quella. Ride Sasha e piangono gli avversari, proprio come ha promesso Sergej. Alè-gria. Con una elle sola. In deroga.
Non è certamente un fuoriclasse, Sergej, ma un buon giocatore, abbastanza dotato tecnicamente molto intelligente dal punto di vista tattico. Viene schierato da Zoff, come centrocampista davanti alla difesa, anche se in carriera ha giocato anche come difensore centrale, come in occasione della finalissima del Campionato Europeo del 1988 nella quale, mancando i difensori titolari Bessonov e Kutnetsov, gli tocca l’improbo compito di marcare Marco Van Basten.
Con la squadra bianconera, disputa 49 presenze, mettendo a segno 3 gol, contribuendo in modo determinante alla conquista della Coppa Italia e della Coppa Uefa. La stagione successiva, con l’arrivo di Maifredi, è ceduto al Lecce, dove giocherà con il futuro capitano juventino, allora giovanissimo, Antonio Conte.
GAETANO MOCCIARO, TUTTOJUVE.COM DEL 5 APRILE 2012
L’ex centrocampista bianconero Sergej Alejnikov apre i cassetti della memoria raccontando la sua esperienza alla Juve e le vicissitudini che lo portarono al trasferimento a Torino prima e a Lecce poi, facendo un paragone col calcio dell’epoca e quello attuale.
– Innanzitutto cosa sta facendo adesso?
«Alleno il Kras, squadra di Eccellenza del Friuli-Venezia Giulia. È un ritorno, il mio, dopo esservi arrivato 4 anni fa e quest’anno in squadra c’è anche mio figlio Artur, classe 1991, che gioca un po’ come giocavo io anche se con caratteristiche più offensive».
– Com’è arrivato ad allenare il Kras?
«Come nella vita molte cose avvengono casualmente. Quando facevo il Corso Master a Coverciano ho conosciuto il presidente del Kras e abbiamo parlato un po’. Abbiamo deciso di provare a lavorare insieme, questo 4 anni fa. La società era giovane ed io come allenatore pure, essendo freschissimo di Coverciano. Comunque l’impatto fu positivo e siamo rimasti amici anche quando il rapporto è terminato. Poi ci siamo risentiti e quest’anno eccomi di nuovo al timone della squadra».
– Lei è stato uno dei primissimi sovietici a lasciare il proprio paese per giocare all’estero. Era così difficile per voi pionieri avventurarsi in una nuova realtà?
«Il discorso secondo me va spostato non tanto sul fatto che eravamo i primi a giocare fuori, perché se guardi bene anche oggi gente come Pavljucenko o Arsavin è tornata indietro dopo essere stata in Inghilterra. È una questione di carattere. Io ad esempio giocavo nella Nazionale sovietica da 8 anni e ho avuto possibilità di viaggiare e vedere i paesi. Eravamo spesso a Coverciano, stavamo in ritiro e in qualche modo avevo già conosciuto l’Italia. Perciò non ho mai avuto problemi di ambientamento».
– Non tutti sanno che in realtà in Italia non l’ha portata la Juventus ma un’altra società.
«Esatto, è stato il Genoa a portarmi in Italia. All’epoca il professor Scoglio mi voleva nella sua squadra, sono arrivato a Genova per cominciare a discutere il contratto. Mentre aspettavamo i dirigenti per chiudere è intervenuta la Juve. E la storia è cambiata».
– Insomma, un tradimento nei confronti del Genoa.
«Non direi, perché hanno fatto tutto i dirigenti della mia ex squadra, la Dinamo Minsk. Anche se la situazione era ben più complessa, perché in Unione Sovietica la situazione era particolare. In pratica la Dinamo Minsk, come tutte le squadre denominate Dinamo erano sotto il Ministero dell’Interno, perciò qualsiasi cosa doveva passare da Mosca. Non c’erano le squadre professionistiche ed io stesso ero dipendente del Ministero dell’Interno. Erano loro a decidere, mi hanno detto: domani si chiude il mercato, firma qui. Ed io ho firmato».
– Era il 1989. Un anno alla Juve che ha portato una vittoria in Coppa Italia e Coppa Uefa. Insomma, non male.
«In realtà è andata male. Ho saputo che avevo firmato un contratto di 3 anni, poi seppi che dopo un anno se la Juve non mi voleva più, c’era una clausola nella quale doveva pagare un indennizzo. In ogni caso non era certo la mia intenzione, dopo aver vinto 2 trofei al primo anno, di andarmene. Per quale motivo avrei dovuto? Anche Zoff fu mandato via dopo quello che aveva fatto. Dico io: vinci 2 coppe e anziché rinforzarti mandi via quasi tutti?».
– Cosa successe?
«Io posso parlare per me. Non sapevo niente del fatto che sarei andato a fine stagione al Lecce. Mi gestiva una società di Padova che controllava i cartellini dei giocatori che erano all’epoca alla Dinamo e li piazzava dove voleva. Io come molti altri sovietici non avendo mai avuto un contratto prima d’ora non sapevamo come funzionasse, non conoscevamo i nostri diritti».
– Parlando di calcio giocato che ricordi le ha lasciato l’esperienza alla Juve?
«Come il primo amore. Nel bene o nel male ti resta nel cuore. Ho trovato persone squisite, su tutti Gaetano Scirea che mi stette vicino durante i miei primi giorni. È stato importantissimo nell’aiutarmi a inserirmi nella squadra. Ho conosciuto la moglie e il figlio che ogni tanto sento ancora».
– A differenza sua il connazionale Zavarov non si ambientò. Perché?
«Non voglio entrare troppo nello specifico, certamente il problema è stato di tipo caratteriale. E poi i giornalisti sono in grado di portare un giocatore tanto in alto quanto in basso. Nel senso che se vedono un giocatore che finito l’allenamento scappa subito a casa e lo fa una volta, lasciano passare. Poi, lo rifà la seconda, la terza, la quarta e allora cominciano a ricamarci su. Il punto è che bisogna distinguere l’uomo dal calciatore e come calciatore su Zavarov penso non ci sia molto su cui discutere».
– Forse le aspettative su di lui erano alte, per questo ha suscitato clamore.
«Vero anche questo, ma d’altronde doveva sostituire un mito come Michel Platini ed era una cosa davvero difficile».
– Lei l’ha più sentito?
«Pochissime volte, da quando ha lasciato la Francia, che è stata la sua tappa successiva all’Italia, è tornato in Ucraina. Mi capita di rivederlo per qualche partita di beneficienza. Il rapporto fra noi è molto buono e adesso so che si occupa dell’organizzazione degli Europei del 2012».
– Meglio Torino o Lecce?
«Dal punto di vista calcistico passando dalla Juve al Lecce ci ho rimesso ma dal punto di vista umano nel Salento mi sono trovato benissimo, è un posto stupendo».
– È più tornato a Torino? Possiamo definirla italiano, ormai.
«Quando mi capita vengo spesso alla Juve, anche perché c’è mio figlio. Più che italiano sono cosmopolita. Oltre all’Italia ho visto altri paesi, come il Giappone, dove vi ho giocato 4 anni, o la Svezia. Mi spiace solo non essere stato negli Stati Uniti».
– Rispetto ai suoi tempi che differenze trova nel calcio?
«Vedo un calcio malato. Purtroppo prevalgono i soldi, gli interessi. E poi non per caso succedono casini, come quello delle scommesse. Ai miei tempi allo stadio vedevi tante persone, genitori con i figli, un’atmosfera diversa. Ora c’è paura ad andare allo stadio e si guarda la partita in TV».
– Il nuovo stadio della Juve ha dato una spinta importante nel riportare la gente allo stadio.
«Ed è questa la cosa più importante. Se poi arriva anche il business non c’è niente di male. Ma l’importante, per il bene del calcio, è che si riempiano di nuovo gli stadi».
 parmaE' un Venezia che segna tanto: in gol in dieci gare su undici in questo campionato
parmaE' un Venezia che segna tanto: in gol in dieci gare su undici in questo campionato
 fiorentinaBONGIORNI A RFV, Parisi ottimo da esterno alto, ma servono colpitori di testa
fiorentinaBONGIORNI A RFV, Parisi ottimo da esterno alto, ma servono colpitori di testa
 avellinoPazienza può ripartire da Trapani, contatti in corso
avellinoPazienza può ripartire da Trapani, contatti in corso
 interMaterazzi provoca: "Lukaku non ha ancora dimostrato che Conte ha fatto bene a volerlo"
interMaterazzi provoca: "Lukaku non ha ancora dimostrato che Conte ha fatto bene a volerlo"
 championsleagueSalisburgo, Lijnders: "Abbiamo zittito i tifosi del Feyenoord, ci siamo tolti un peso"
championsleagueSalisburgo, Lijnders: "Abbiamo zittito i tifosi del Feyenoord, ci siamo tolti un peso"
 milanFlorenzi alla dirigenza nello spogliatoio del Bernabeu: "Dateci un iPad per tutti. Per rivedere Real-Milan"
milanFlorenzi alla dirigenza nello spogliatoio del Bernabeu: "Dateci un iPad per tutti. Per rivedere Real-Milan"
 bolognaRipresa degli allenamenti verso #RomaBFC: seduta di scarico per i titolari in Champions
bolognaRipresa degli allenamenti verso #RomaBFC: seduta di scarico per i titolari in Champions
 palermoPalermo, gli appuntamenti del settore femminile e giovanile
palermoPalermo, gli appuntamenti del settore femminile e giovanile